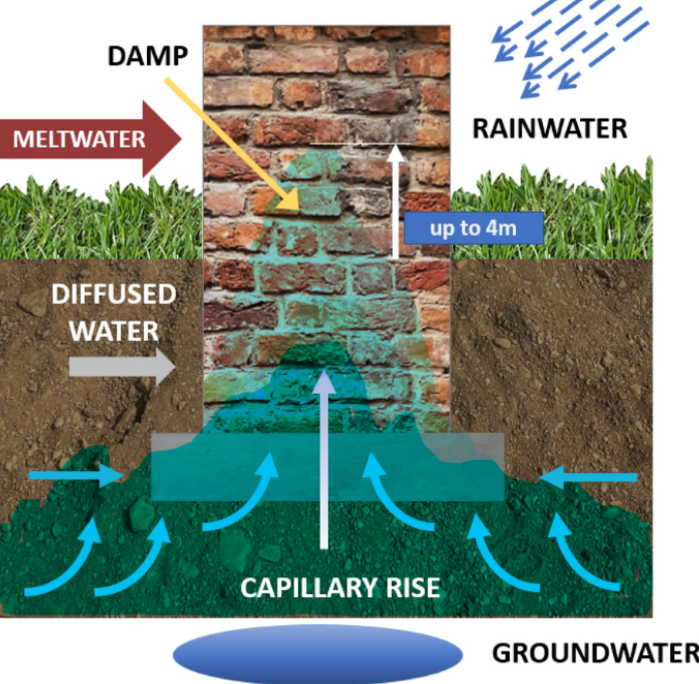Inquinamento e tumore al polmone: come lo smog modifica il DNA e cosa possiamo fare
Immagina di uscire di casa per andare al lavoro. È una mattina tranquilla, magari c’è un bel sole e l’aria sembra “pulita”. Ma non lo è. Invisibili all’occhio e inodori, nell’aria che respiriamo ogni giorno si nascondono particelle minuscole che entrano nei nostri polmoni e, secondo studi recentissimi, possono modificare il nostro DNA, aumentando il rischio di sviluppare tumori. Anche se non abbiamo mai fumato una sigaretta in vita nostra.
Può sembrare incredibile, ma oggi la scienza ci dice con chiarezza che l’inquinamento atmosferico ha un impatto diretto sulla nostra salute genetica. E questo vale anche (e soprattutto) per chi pensa di essere “fuori pericolo” perché non fuma.

lo smog modifica il DNA
Il tumore del polmone: non solo colpa del fumo
Ogni anno, nel mondo, vengono diagnosticati circa 2,5 milioni di nuovi casi di tumore del polmone. Il fumo rimane la causa principale, ma tra il 10% e il 25% dei casi riguarda persone che non hanno mai fumato. Questo dato è in crescita, in particolare nei paesi industrializzati dove il numero di fumatori è in calo ma l’inquinamento atmosferico rimane alto.
Il tumore del polmone è oggi la prima causa di morte oncologica a livello globale: secondo le stime del Global Cancer Observatory dell’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), nel solo 2020 sono morte 1,8 milioni di persone a causa di questa malattia. In Italia, secondo l’AIRTUM, ne è colpito 1 uomo su 10 e 1 donna su 35 nel corso della vita.
Ma come è possibile che anche i non fumatori si ammalino? Qual è il ruolo dell’aria che respiriamo?
Lo studio Sherlock-Lung: la prova è scritta nel DNA
Un recente studio pubblicato su Nature ha portato nuove e impressionanti evidenze: l’esposizione allo smog urbano può causare mutazioni genetiche associate al tumore del polmone, anche in persone che non hanno mai fumato.
Lo studio, chiamato Sherlock-Lung, ha analizzato il genoma di 871 pazienti non fumatori provenienti da Europa, America, Asia e Africa. I ricercatori, guidati dal professor Ludmil Alexandrov dell’Università della California a San Diego, hanno confrontato questi dati genetici con le informazioni satellitari e ambientali relative all’inquinamento dell’aria nei luoghi dove vivevano i pazienti.
Il risultato? Chi vive in zone più inquinate presenta un numero significativamente maggiore di mutazioni genetiche nei polmoni, alcune delle quali (come quelle del gene TP53) sono ben note per il loro legame con lo sviluppo di tumori. Inoltre, i soggetti più esposti mostravano telomeri più corti – un chiaro segno di invecchiamento cellulare precoce – che può favorire lo sviluppo di cellule malate.
Il principale responsabile è il particolato fine PM2.5, un inquinante presente nell’aria delle città, prodotto da traffico, riscaldamento, industria. Questo materiale riesce a penetrare in profondità nei polmoni, danneggiando le cellule e alterando i processi di replicazione del DNA.
Ridurre l’inquinamento si può: cominciamo da casa
Non possiamo eliminare lo smog urbano con uno schiocco di dita. Ma possiamo fare molto nel nostro piccolo per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria – sia fuori che dentro casa.
Ecco alcune azioni concrete che fanno davvero la differenza:
-
🏡 Isolare termicamente gli edifici: un’abitazione ben isolata consuma meno energia per riscaldamento e raffrescamento. Questo significa meno emissioni di CO₂, meno inquinamento e bollette più leggere.
-
⚡ Utilizzare impianti efficienti: scegliere pompe di calore, pannelli solari, pannelli radianti ad infrarossi, sistemi ibridi o caldaie di ultima generazione riduce l’impatto ambientale e migliora il comfort abitativo.
-
🚶♀️ Muoversi in modo sostenibile: quando possibile, privilegiare mezzi pubblici, bicicletta o passeggiate. L’uso massiccio dell’auto privata è una delle principali fonti di smog cittadino.
-
🌬️ Gestire correttamente la ventilazione: aprire le finestre per arieggiare può essere rischioso, soprattutto in città e in orari di punta. In questi casi, è molto più efficace affidarsi a un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC).
La VMC: un alleato silenzioso per la salute
Anche se non può risolvere il problema alla radice, la VMC rappresenta una soluzione concreta e quotidiana per migliorare la qualità dell’aria indoor. Questi impianti, se dotati di filtri ad alta efficienza, riescono a:
-
rimuovere particolato fine, pollini, spore e altre sostanze nocive;
-
ricambiare l’aria in modo continuo, senza necessità di aprire le finestre;
-
mantenere un microclima salubre, controllando anche l’umidità.
In un contesto in cui l’inquinamento è ormai parte del nostro vivere quotidiano, proteggere l’aria che respiriamo dentro casa diventa un gesto di responsabilità verso noi stessi e verso chi ci sta vicino.
Fonti:
-
Alexandrov L.B. et al., “Mutational signatures in lung cancer in never smokers”, Nature, 2024
-
National Institutes of Health – nih.gov
-
Inside Precision Medicine, “Air Pollution Revealed as Major Driver of Lung Cancer in Never-Smokers”
-
Global Cancer Observatory – IARC, 2020
-
AIRTUM – Associazione Italiana Registri Tumori
- FOCUS: “L’inquinamento atmosferico è legato a mutazioni genetiche che favoriscono il tumore del polmone”
-
Unilab.eu – “La VMC e la qualità dell’aria negli ambienti indoor”